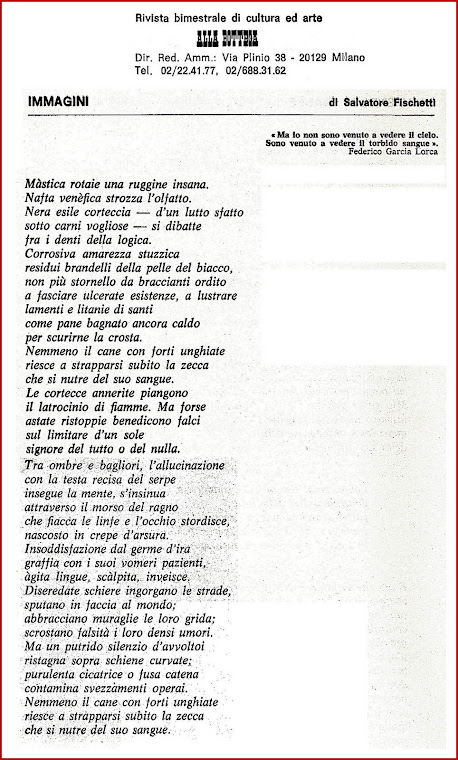LU NUTU ALL'AZZA (Il nodo al filo)
PREMESSA
Lu nutu all’azza (Il nodo al filo), brevissima, semplice ed essenziale silloge nel dialetto corrente di Lizzano, composta di ulteriori piccole “schegge” di salentinità (non tutte o del tutto inedite), nasce come mio personale e schietto omaggio a Rino Contessa, la cui incoraggiante “connivenza”, circa un quarto di secolo fa, rese possibile l’inizio di un per me molto importante percorso che mi condusse alla stampa della raccolta Scardi (Versi in vernacolo lizzanese), (Fasano, Schena editore, 1982, pp. 100), brillantemente introdotta da Rosario Jurlaro e illustrata con disegni di Giovanni Pisconti.
Luci
Chiúcu li uécchi e ttegnu tanta luci.
Lu ciélu pó scuréri ciéntu voti,
ma cuštu soli ‘m piéttu nonci pónni.
Rátichi fuérti t’aruli crišciuti
- lu bbeni ti la mamma, ti lu tata –
a nnui fugghiázzi ppont’a jérti mappi
nni mánnunu lu sucu ti la vita:
muétu, fatía, forza ti campári,
lu cori sempri apiértu a ppirdunári.
LUCE
Socchiudo gli occhi e serbo tanta luce. Il sole può oscurarsi mille volte, ma questo sole in petto mai tramonta. Radici salde di alberi cresciuti – l’affetto della mamma e del papà – a noi foglie in cima ad alti rami consegnano l’essenza della vita: rettitudine, lavoro, forza di vivere, il cuore sempre pronto a perdonare.
Pígghia nómina e ffusci…
Pígghia nómina e ffusci. Cuštu conta.
Ma segna e tti cuntiénti ci ué ggudi
e mminti sempri lu zzippu ddonca arrívi.
Ricórditi: ogne nziddu faci štedda,
comu puru ogne ppetra oza paréti.
Macára ca ogne ffilu veni a ppéttini,
bbatti lu fiérru sempri quannu è’ ccáutu.
Cce ppriésciu, allu trappítu! A onza a onza
lu uégghiu bbuénu enchi la cannáta.
Ti cuddu uégghiu tu no tti šcirrári,
ca sempri á štatu e ssinti luci ferma
comu lampa ca ardi e mmai si štuta.
Pígghia nómina e ffusci. Cuštu conta.
Ca ci la vita ti jaštéma e ssegna,
tu fatti forti, jabba e ttiéni a mmenti:
«A ccaváddu jaštimátu luci lu pilu».
ACQUISTA FAMA E PROSEGUI (IL TUO CAMMINO)…
Acquista fama e prosegui. Questo conta. Ma devi contentarti se vuoi deliziarti e metti sempre il segnacolo dei tuoi limiti. Ricòrdati: ogni goccia produce altra goccia, come pure pietra su pietra nasce il muro. Benché ogni filo venga al pettine, batti sempre il ferro quando è caldo.
Che gioia, nel frantoio! A goccia a goccia, l’ottimo olio riempie il recipiente. Di quell’olio tu mai non scordarti, poiché sei sempre stato e sei luce tenace, come di lampada che arde e mai si spegne.
Acquista fama e prosegui. Questo conta. Ché se pure la vita inveisse contro di te e ti lasciasse i segni, tu stringi i pugni, ignora e non scordarti: “Al cavallo bestemmiato luccica il pelo”.
Miéru vécchiu
A cci mi bbevi cu rringrázzia Ddiu
ca acqua tesi, soli e bbona terra,
pi ffari mpassulá’ li crappi gnori;
a Ddiu ca feci amaru lu sutóri
ti setti, vinti, ciéntu fatiatúri,
comu amáru sont’iu alla bbuccáta,
ma forti, sangu víu, soli, suštánza!
VINO INVECCHIATO
Chi mi beve ringrazi Iddio che donò acqua, sole e buon terreno, per fare maturare i grappoli neri; Iddio che fece amaro il sudore di sette, venti, cento lavoratori, come amaro son io all’assaggio, ma robusto, simile a sangue vivo, sole, sostanza!
Lu criaturiéddu
«Ttinzió, no lli tuccá’ lu muddalúru!
A bbellu bbellu, ví’ cu nno llu sbáddi,
lu criaturiéddu ca si šté vvavéscia
sucánnu lu pupiéddu zzuccarátu!…».
Šta ffaci vota e sbota ntra lla naca,
riti pi ccuntu sua, li uécchi sdramma
ci si triménti fittu li manóddi;
ddurméšci quannu “Páulu” vaštási
lu bbabbuléscia cu vvintágghi t’oru.
Nfigna a ccremmáni, ntra nnu cori cranni,
pó zzumpisciá’, ddó lupu e ppicurédda,
sciardénuri ti luci, latti e mmeli,
si vonu caminánnu; egghi-éti amóri
lu šcamarízzu ‘n terra ti la naca,
lu passu cittu cittu, lu suspíru
ca énchi toci toci ti rifína
la cammarédda própia nn’ogna scura.
E ntra llu suénnu scápula lu ninni:
fassa sbrugghiáta, štágghiu a ppani-cuéttu,
e mmanu manu vái cu Rre Pupínu.
Ci lu sapía cce mmunnu lu šta spétta,
cce rrazza ti crištiáni vónu a ggiru,
no llu lassáva srái lu pani-cuéttu,
no lli scuccáva srái cu scapuláva.
IL PICCININO
«Attento, non toccargli la fontanella! Fa’ pian pianino, bada a non scuoterlo, il piccinino che tutto si sbava succhiando il succino zuccherato!...».
Si gira e si rigira nella culla, ride per suo conto, gli occhietti storce per guardarsi fittamente le manine; si addormenta quando “Paolo” (il sonno) birichino lo incanta con ventagli dorati.
Fino a domattina, in un cuore immenso, potrà saltellare, dove il lupo e la pecorella gironzolano in giardini di luce, latte e miele; ed è amore
il cigolio della culla sul pavimento, il passo silenziosissimo (della mamma), il respiro che riempie di dolcissima pace la cameretta proprio un tantino buia.
E nel sonno muove i suoi primi passi, il piccino: le fasce ormai sbrogliate, lo svezzamento con pancotto, e mano nella mano va con Re Pupino. Se sapesse qual è la realtà che lo attende,
che razza di persone esistono sulla faccia della Terra, non lo lascerebbe forse il pancotto, non li darebbe forse i primi passi.
L’anítu
Tre ccurciulícchi ntra ll’anítu, ‘n terra,
‘mmiénz’alli šcrasci šciáncunu la vocca,
ci cuétuli nnu zzippu ti cicóra;
nancáta riciddéa mancu mpinnáta,
sott’a nna chióppa t’umbri ngià mmiláta.
Faci la páccia mamma cucusédda
ca srái nnu virmizzúlu li vó’ nnuci:
si ppóggia mo’ a nnu scuérpu, mo’ a nnu truddu,
vol’alla larga, nfitta ti luntánu.
IL NIDO
Tre uccellini nel nido, sul terreno, nell’intrico dei rovi sciancano la bocca, se smuovi uno stelo di cicoria; ingordo pigolio ancora implume, sotto un grappolo di more già mature. Non si dà pace la mamma lodoletta, che forse un vermetto gli vuol portare: si appoggia ora su uno sterpo, ora su un trullo, vola a distanza, sbircia da lontano.
Ah, ci tilóri éra lu vulári…
Cardíllu mpirnicátu a nnu laúzzu:
ci fišca, mai nišciúnu li rispónni.
Ah, ci tilóri era lu vulári
ti l’anítu a nnu cardu fiurítu!
Filu ca luci nfiáma nna cicóra
all’ombra ti nna šcráscia: ringatéla,
ca cchiú no ppo’ jabbá’ lu curnacchiúlu,
si squárta totta zínzuli allu jéntu,
mascía ca la jaštéma sputtanóu.
Štidda ti sangu, pi nna pungitóra,
júnnuli ddišcitóu, spanníu la voci,
li carni rrizzicóu, šcantóu lu cori:
cammísa ti scurzóni štrascináta,
lassáta poi ppinnúta a nnu curmóni.
Ah, ci tilóri era lu vulári
ti l’anítu a nnu cardu fiurítu!
AH, SE IL DOLORE FOSSE VOLARE…
Cardellino aggrappato a un asfodelo: se cinguetta, mai nessuno gli risponde. Ah, se il dolore fosse volare dal nido a un cardo in fiore!
Un filo rilucente imbastisce una cicoria nel folto di un roveto: ragnatela, che non può più ingannare la farfalletta, si dilacera in mille brandelli al vento, malìa che la bestemmia rivelò…
Goccia di sangue, per una trafittura, onde risvegliò, sparse la voce, le carni fece rabbrividire, spaventò il cuore:
pelle di serpe nera trascinata, lasciata poi appesa ad un tronco. Ah, se il dolore fosse volare dal nido ad un cardo in fiore!
Spiránza
Musica come parole… penetrava in loro non per le vie della comprensione, ma per altre più remote che pareva impegnassero tutti i sensi.
Rosario Jurlaro, La festa cresta, Ravenna, Longo Editore,1983, cap. I, p. 14.
Palóri comu fuéchi ti la fešta
ntra llu scuróri šcántunu arduránnu
e nchiánunu a vvasá’ jérti li štéddi.
Ricámu rosi rosi si sparpágghia
e ntra llu cori nzédduri ti luci
tónu culóri e ária alla spiránza:
pani ti furnu cádducu, ndurátu,
pi ccinca lu maštíca.
Ma a štu munnu,
quantu sbintúri, quantu sbinturáti!
Scurnáti, frašturnáti nni ni sciámu
ntra llu urtígghiu ti sciurnáti amári,
ciúcci ti ngégna nturnu a nnu uccáli:
mitóddi cotti e lla sacchétta chiéna
ti págghia e bbiáva urdi e ssamuráti.
Ma ci nni voli piátti ti sibbúrcu,
chiantóddi nati mísiri allu scuru?
Sott’alla quinta-décima ti marzu
puru Quarémma riti quánnu ardi;
e mmovi parmi novi lu Sannáli,
li quattru jénti mbrazza a ttutti l’ori.
Campáni scapuláti, “réssu réssu”,
e ffrájutu ntra ccasa a ogne ccantóni:
nna vota ci cacciátu cu nno ppéta,
lu tiáulu nfamóni!
Ma cce-gghi-éti
šta vita trišta ca mo’ nni šté’ ttocca?
Ma ci é’ cca vó’ lu munnu rivutátu?
Lu cori voli ária, terra, soli,
e vvoli nn’otru cori pi ccantári!
SPERANZA
Parole come i fuochi pirici festivi nel buio fanno sobbalzare odorosi e salgono a baciare alte le stelle. Ricamo tutto a rose si sparpaglia e dentro al cuore gocce di luce danno colore e voce alla speranza: pane di forno soffice, dorato, per chi sempre riesca a masticarlo.
Ma sulla Terra, quante disgrazie, quanti sventurati! Scornati, frastornati ce ne andiamo negli orti di giorni tribolati, come ciuchi di noria intorno al pozzo: le midolla cotte e la sacca ricolma di paglia e biada umide e insapori.
Ma chi ci vuole come piatti dei sepolcri (quaresimali, del Giovedì santo), come piantine nate stente al buio? Sotto la luna piena marzolina – pure Quaremba ride mentre arde; e àgita le nuove palme, l’Osanna, i quattro punti cardinali abbraccia in ogni momento. Ecco lo scampanio di campane liberate, il “Resurrexit”, e un fracasso diffuso in ogni angolo domestico: una volta scacciato più non torni, il diavolo infame!
Ma cos’è questa vita tribolata che ora ci tocca vivere? E chi è che vuole il mondo sconquassato? Il cuore vuole aria, terra, sole, e vuole un altro cuore per cantare!
All’ombra ti lu spízziu
Nui ti ccattámmu latti ti cardíllu
cu tti crišcémmu mégghiu ca putémmu.
No nni primía ti núi quantu ti téi.
An táula, alli scoli, ‘m Paratísu…
cu llu sutóri tuttu fó’ vulútu.
Ci mo’ tu tieni nomi e ttiéni voci,
fora li jendritía ti quarantána
ca no ccummémmu ventri, pi sparágnu.
Crišcíšti forti, avíšti cce nno avémmu;
e ssínti cce vvulíšti (cce vvulémmu):
nzurátu, sištimátu, ncivilútu.
Lu cori si canóšci allu bbisuégnu.
Ci la nucérta vó’ ssi šté’ alla ráscia,
trišta nucérta, ci la ráscia manca!
All’ombra ti lu spízziu vái calánnu
nnu cori ca pi ffá’ bbeni mali é ‘útu.
ALL’OMBRA DELL’OSPIZIO
Noi non ti facemmo mancare proprio nulla, nemmeno il “latte” di cardellino, per farti crescere meglio che si potesse. Non ci importava di noi, ma piuttosto badavamo a te. Cibo, istruzione, benessere… con i sacrifici tutto fu voluto e raggiunto. Se ora tu sei uno che conta, lo devi a tutte le nostre privazioni. Crescesti in buona salute, avesti ciò che noi mai avevamo avuto; e sei quello che scegliesti di essere (e che in cuor nostro auspicavamo): sposato, sistemato, istruito. Il cuore si conosce nelle avversità. Se la lucertola vuole bearsi ai raggi del sole, povera la lucertola se il sole manca! All’ombra di un ospizio va spegnendosi un cuore dalla bontà mal ripagata.
Taránta
Malincunía : tammúrru cupu cupu,
cicóra t’amaróri ntra llu cori,
nturnísciu ti sutóri, rággia ‘n cuérpu.
Tu, Lena ti “scupétta” cantatríci,
ué’ scázzichi šta chiánca e bbatti a ssuénu
la péddi ti tammúrru e nnonci štracchi.
Šta pparla lu tammúrru senza voci,
cu llu sua tunghi-tunghi, tunghi-tunghi,
‘n capu a cci teni fami ti lu gghiúštu :
“Nnu túmmunu a mmé’,
nnu túmmunu a tté’, massaru Miché !
Nnu túmmunu a mmé’,
nnu túmmunu a tté’, massaru Miché !
Nnu túmmunu a mmé’,
nnu túmmunu a tté’, massáru Miché !…”.
Intr’alla štrata totta nzulagnáta
lu uécchi fissu ti la tarantáta
šta spetta cu lla pongi lu culóri
ti la taránta ca l’é pizzicáta.
Ttacca, viulínu, tágghia cu llu suénu,
tagghiénti comu filu ti rasúlu,
la tantazzióni e lla malincunía !
A šta carósa mia talli rifína,
falla bballá’ cu ccáccia fuécu e rrággia !
“A mmari vani tuni, a mmari vegnu…”,
a ccuddu mari ci ti tesi amóri,
a ccuddu mari ci ti feci amára ;
“ci vecu ca ti ffuéchi, mi ni tornu,
ci vecu ca ti ffuéchi, mi ni tornu”.
Ah, soli, soli ca šta ardi ‘n ciélu,
štrazza li ggiúrni ti li spini amári,
nducíšci šti sciurnáti ti chiatróri,
am piéttu a šta carósa minti priésciu !
Ci mó ti cantu, tu rispúnni a mméi,
rispúnni comu aciéddu cantatóri
ca ntra lla cággia si senti šcattári.
A ddó ti pizzicóu la tarantélla,
a ddá cu bballu e ssuénu vani tuni,
a ddó lu fumu ti cicóu li uécchi,
a ddó la fantasía si ni vulóu…
A bballa, bbédda, comu mai facíšti,
no tti ppuggiári, bballa, bballa, bballa !
Ddurmíšci la taránta tantatríci,
a ccantu e ssuénu, bballa, bballa, bballa !
Šta mbrógghia, Lena comu voli e ssapi
cuddu latuérnu ca pi edda é’ ppani ;
sona Pascáli, senti, nonci veti,
pi nna taránta nfama, traditóra,
ca li štutóu la luci ti lu soli.
Allu círchiu, nna bbotta, e allu tampágnu :
“No é’ ttaránta ca t’é pizzicáta,
cuštu é’ llu tiáulu ci ‘n capu t’á misu…
cuštu é’ llu tiáulu ci ‘n capu t’á misu”,
pi qquédda spica ca tu no ccugghjíšti,
pi ccuddu soli ca tu no vvitíšti.
“Amóri, amóri, cce mm’á fattu fari ?…” :
lu cori allécru mia mó é’ nnu scuróri,
tinía nna bbedda voci, mó é’ bbrucáta,
ticía bbeddi palóri, mó no cchiúni !
“Amóri, amóri, cce mm’á fattu fari ?
Ti quínnici-anni m’á fatta mpaccéri !”.
A bballa, bbedda, comu mai facíšti,
no tti ppuggiári, bballa, bballa, bballa !
Ddurmíšci la taránta tantatríci,
a ccantu e ssuénu, bballa, bballa, bballa !
E quannu ponni la malincunía,
quannu nnu jéntu finu comu seta
ti ccúccia ntra nnu liéttu ti rifína,
oi bbedda mia, ripígghjiti li ggiúrni !
Fešta, uttisciána, sempri allu scampíštru,
lu cori fallu bbáttiri, šciuntári !…
Ca lu sunágghiu ti nna bbona cera
scázzica si faci a rrimmuddári
quédda taránta pronta a pizzicári,
spuntánnu allu pizzúlu ti la štrata.
TARANTOLA
Malinconia: tamburo disperato, opprimente amarezza dentro il cuore, turbinio di sudore, rabbia dentro.
Tu, Lena di “scupètta” [=soprannome] cantatrice, vuoi rimuovere questo peso e suonando batti la pelle del tamburo instancabilmente.
Lu nutu all’azza (Il nodo al filo), brevissima, semplice ed essenziale silloge nel dialetto corrente di Lizzano, composta di ulteriori piccole “schegge” di salentinità (non tutte o del tutto inedite), nasce come mio personale e schietto omaggio a Rino Contessa, la cui incoraggiante “connivenza”, circa un quarto di secolo fa, rese possibile l’inizio di un per me molto importante percorso che mi condusse alla stampa della raccolta Scardi (Versi in vernacolo lizzanese), (Fasano, Schena editore, 1982, pp. 100), brillantemente introdotta da Rosario Jurlaro e illustrata con disegni di Giovanni Pisconti.
Luci
Chiúcu li uécchi e ttegnu tanta luci.
Lu ciélu pó scuréri ciéntu voti,
ma cuštu soli ‘m piéttu nonci pónni.
Rátichi fuérti t’aruli crišciuti
- lu bbeni ti la mamma, ti lu tata –
a nnui fugghiázzi ppont’a jérti mappi
nni mánnunu lu sucu ti la vita:
muétu, fatía, forza ti campári,
lu cori sempri apiértu a ppirdunári.
LUCE
Socchiudo gli occhi e serbo tanta luce. Il sole può oscurarsi mille volte, ma questo sole in petto mai tramonta. Radici salde di alberi cresciuti – l’affetto della mamma e del papà – a noi foglie in cima ad alti rami consegnano l’essenza della vita: rettitudine, lavoro, forza di vivere, il cuore sempre pronto a perdonare.
Pígghia nómina e ffusci…
Pígghia nómina e ffusci. Cuštu conta.
Ma segna e tti cuntiénti ci ué ggudi
e mminti sempri lu zzippu ddonca arrívi.
Ricórditi: ogne nziddu faci štedda,
comu puru ogne ppetra oza paréti.
Macára ca ogne ffilu veni a ppéttini,
bbatti lu fiérru sempri quannu è’ ccáutu.
Cce ppriésciu, allu trappítu! A onza a onza
lu uégghiu bbuénu enchi la cannáta.
Ti cuddu uégghiu tu no tti šcirrári,
ca sempri á štatu e ssinti luci ferma
comu lampa ca ardi e mmai si štuta.
Pígghia nómina e ffusci. Cuštu conta.
Ca ci la vita ti jaštéma e ssegna,
tu fatti forti, jabba e ttiéni a mmenti:
«A ccaváddu jaštimátu luci lu pilu».
ACQUISTA FAMA E PROSEGUI (IL TUO CAMMINO)…
Acquista fama e prosegui. Questo conta. Ma devi contentarti se vuoi deliziarti e metti sempre il segnacolo dei tuoi limiti. Ricòrdati: ogni goccia produce altra goccia, come pure pietra su pietra nasce il muro. Benché ogni filo venga al pettine, batti sempre il ferro quando è caldo.
Che gioia, nel frantoio! A goccia a goccia, l’ottimo olio riempie il recipiente. Di quell’olio tu mai non scordarti, poiché sei sempre stato e sei luce tenace, come di lampada che arde e mai si spegne.
Acquista fama e prosegui. Questo conta. Ché se pure la vita inveisse contro di te e ti lasciasse i segni, tu stringi i pugni, ignora e non scordarti: “Al cavallo bestemmiato luccica il pelo”.
Miéru vécchiu
A cci mi bbevi cu rringrázzia Ddiu
ca acqua tesi, soli e bbona terra,
pi ffari mpassulá’ li crappi gnori;
a Ddiu ca feci amaru lu sutóri
ti setti, vinti, ciéntu fatiatúri,
comu amáru sont’iu alla bbuccáta,
ma forti, sangu víu, soli, suštánza!
VINO INVECCHIATO
Chi mi beve ringrazi Iddio che donò acqua, sole e buon terreno, per fare maturare i grappoli neri; Iddio che fece amaro il sudore di sette, venti, cento lavoratori, come amaro son io all’assaggio, ma robusto, simile a sangue vivo, sole, sostanza!
Lu criaturiéddu
«Ttinzió, no lli tuccá’ lu muddalúru!
A bbellu bbellu, ví’ cu nno llu sbáddi,
lu criaturiéddu ca si šté vvavéscia
sucánnu lu pupiéddu zzuccarátu!…».
Šta ffaci vota e sbota ntra lla naca,
riti pi ccuntu sua, li uécchi sdramma
ci si triménti fittu li manóddi;
ddurméšci quannu “Páulu” vaštási
lu bbabbuléscia cu vvintágghi t’oru.
Nfigna a ccremmáni, ntra nnu cori cranni,
pó zzumpisciá’, ddó lupu e ppicurédda,
sciardénuri ti luci, latti e mmeli,
si vonu caminánnu; egghi-éti amóri
lu šcamarízzu ‘n terra ti la naca,
lu passu cittu cittu, lu suspíru
ca énchi toci toci ti rifína
la cammarédda própia nn’ogna scura.
E ntra llu suénnu scápula lu ninni:
fassa sbrugghiáta, štágghiu a ppani-cuéttu,
e mmanu manu vái cu Rre Pupínu.
Ci lu sapía cce mmunnu lu šta spétta,
cce rrazza ti crištiáni vónu a ggiru,
no llu lassáva srái lu pani-cuéttu,
no lli scuccáva srái cu scapuláva.
IL PICCININO
«Attento, non toccargli la fontanella! Fa’ pian pianino, bada a non scuoterlo, il piccinino che tutto si sbava succhiando il succino zuccherato!...».
Si gira e si rigira nella culla, ride per suo conto, gli occhietti storce per guardarsi fittamente le manine; si addormenta quando “Paolo” (il sonno) birichino lo incanta con ventagli dorati.
Fino a domattina, in un cuore immenso, potrà saltellare, dove il lupo e la pecorella gironzolano in giardini di luce, latte e miele; ed è amore
il cigolio della culla sul pavimento, il passo silenziosissimo (della mamma), il respiro che riempie di dolcissima pace la cameretta proprio un tantino buia.
E nel sonno muove i suoi primi passi, il piccino: le fasce ormai sbrogliate, lo svezzamento con pancotto, e mano nella mano va con Re Pupino. Se sapesse qual è la realtà che lo attende,
che razza di persone esistono sulla faccia della Terra, non lo lascerebbe forse il pancotto, non li darebbe forse i primi passi.
L’anítu
Tre ccurciulícchi ntra ll’anítu, ‘n terra,
‘mmiénz’alli šcrasci šciáncunu la vocca,
ci cuétuli nnu zzippu ti cicóra;
nancáta riciddéa mancu mpinnáta,
sott’a nna chióppa t’umbri ngià mmiláta.
Faci la páccia mamma cucusédda
ca srái nnu virmizzúlu li vó’ nnuci:
si ppóggia mo’ a nnu scuérpu, mo’ a nnu truddu,
vol’alla larga, nfitta ti luntánu.
IL NIDO
Tre uccellini nel nido, sul terreno, nell’intrico dei rovi sciancano la bocca, se smuovi uno stelo di cicoria; ingordo pigolio ancora implume, sotto un grappolo di more già mature. Non si dà pace la mamma lodoletta, che forse un vermetto gli vuol portare: si appoggia ora su uno sterpo, ora su un trullo, vola a distanza, sbircia da lontano.
Ah, ci tilóri éra lu vulári…
Cardíllu mpirnicátu a nnu laúzzu:
ci fišca, mai nišciúnu li rispónni.
Ah, ci tilóri era lu vulári
ti l’anítu a nnu cardu fiurítu!
Filu ca luci nfiáma nna cicóra
all’ombra ti nna šcráscia: ringatéla,
ca cchiú no ppo’ jabbá’ lu curnacchiúlu,
si squárta totta zínzuli allu jéntu,
mascía ca la jaštéma sputtanóu.
Štidda ti sangu, pi nna pungitóra,
júnnuli ddišcitóu, spanníu la voci,
li carni rrizzicóu, šcantóu lu cori:
cammísa ti scurzóni štrascináta,
lassáta poi ppinnúta a nnu curmóni.
Ah, ci tilóri era lu vulári
ti l’anítu a nnu cardu fiurítu!
AH, SE IL DOLORE FOSSE VOLARE…
Cardellino aggrappato a un asfodelo: se cinguetta, mai nessuno gli risponde. Ah, se il dolore fosse volare dal nido a un cardo in fiore!
Un filo rilucente imbastisce una cicoria nel folto di un roveto: ragnatela, che non può più ingannare la farfalletta, si dilacera in mille brandelli al vento, malìa che la bestemmia rivelò…
Goccia di sangue, per una trafittura, onde risvegliò, sparse la voce, le carni fece rabbrividire, spaventò il cuore:
pelle di serpe nera trascinata, lasciata poi appesa ad un tronco. Ah, se il dolore fosse volare dal nido ad un cardo in fiore!
Spiránza
Musica come parole… penetrava in loro non per le vie della comprensione, ma per altre più remote che pareva impegnassero tutti i sensi.
Rosario Jurlaro, La festa cresta, Ravenna, Longo Editore,1983, cap. I, p. 14.
Palóri comu fuéchi ti la fešta
ntra llu scuróri šcántunu arduránnu
e nchiánunu a vvasá’ jérti li štéddi.
Ricámu rosi rosi si sparpágghia
e ntra llu cori nzédduri ti luci
tónu culóri e ária alla spiránza:
pani ti furnu cádducu, ndurátu,
pi ccinca lu maštíca.
Ma a štu munnu,
quantu sbintúri, quantu sbinturáti!
Scurnáti, frašturnáti nni ni sciámu
ntra llu urtígghiu ti sciurnáti amári,
ciúcci ti ngégna nturnu a nnu uccáli:
mitóddi cotti e lla sacchétta chiéna
ti págghia e bbiáva urdi e ssamuráti.
Ma ci nni voli piátti ti sibbúrcu,
chiantóddi nati mísiri allu scuru?
Sott’alla quinta-décima ti marzu
puru Quarémma riti quánnu ardi;
e mmovi parmi novi lu Sannáli,
li quattru jénti mbrazza a ttutti l’ori.
Campáni scapuláti, “réssu réssu”,
e ffrájutu ntra ccasa a ogne ccantóni:
nna vota ci cacciátu cu nno ppéta,
lu tiáulu nfamóni!
Ma cce-gghi-éti
šta vita trišta ca mo’ nni šté’ ttocca?
Ma ci é’ cca vó’ lu munnu rivutátu?
Lu cori voli ária, terra, soli,
e vvoli nn’otru cori pi ccantári!
SPERANZA
Parole come i fuochi pirici festivi nel buio fanno sobbalzare odorosi e salgono a baciare alte le stelle. Ricamo tutto a rose si sparpaglia e dentro al cuore gocce di luce danno colore e voce alla speranza: pane di forno soffice, dorato, per chi sempre riesca a masticarlo.
Ma sulla Terra, quante disgrazie, quanti sventurati! Scornati, frastornati ce ne andiamo negli orti di giorni tribolati, come ciuchi di noria intorno al pozzo: le midolla cotte e la sacca ricolma di paglia e biada umide e insapori.
Ma chi ci vuole come piatti dei sepolcri (quaresimali, del Giovedì santo), come piantine nate stente al buio? Sotto la luna piena marzolina – pure Quaremba ride mentre arde; e àgita le nuove palme, l’Osanna, i quattro punti cardinali abbraccia in ogni momento. Ecco lo scampanio di campane liberate, il “Resurrexit”, e un fracasso diffuso in ogni angolo domestico: una volta scacciato più non torni, il diavolo infame!
Ma cos’è questa vita tribolata che ora ci tocca vivere? E chi è che vuole il mondo sconquassato? Il cuore vuole aria, terra, sole, e vuole un altro cuore per cantare!
All’ombra ti lu spízziu
Nui ti ccattámmu latti ti cardíllu
cu tti crišcémmu mégghiu ca putémmu.
No nni primía ti núi quantu ti téi.
An táula, alli scoli, ‘m Paratísu…
cu llu sutóri tuttu fó’ vulútu.
Ci mo’ tu tieni nomi e ttiéni voci,
fora li jendritía ti quarantána
ca no ccummémmu ventri, pi sparágnu.
Crišcíšti forti, avíšti cce nno avémmu;
e ssínti cce vvulíšti (cce vvulémmu):
nzurátu, sištimátu, ncivilútu.
Lu cori si canóšci allu bbisuégnu.
Ci la nucérta vó’ ssi šté’ alla ráscia,
trišta nucérta, ci la ráscia manca!
All’ombra ti lu spízziu vái calánnu
nnu cori ca pi ffá’ bbeni mali é ‘útu.
ALL’OMBRA DELL’OSPIZIO
Noi non ti facemmo mancare proprio nulla, nemmeno il “latte” di cardellino, per farti crescere meglio che si potesse. Non ci importava di noi, ma piuttosto badavamo a te. Cibo, istruzione, benessere… con i sacrifici tutto fu voluto e raggiunto. Se ora tu sei uno che conta, lo devi a tutte le nostre privazioni. Crescesti in buona salute, avesti ciò che noi mai avevamo avuto; e sei quello che scegliesti di essere (e che in cuor nostro auspicavamo): sposato, sistemato, istruito. Il cuore si conosce nelle avversità. Se la lucertola vuole bearsi ai raggi del sole, povera la lucertola se il sole manca! All’ombra di un ospizio va spegnendosi un cuore dalla bontà mal ripagata.
Taránta
Malincunía : tammúrru cupu cupu,
cicóra t’amaróri ntra llu cori,
nturnísciu ti sutóri, rággia ‘n cuérpu.
Tu, Lena ti “scupétta” cantatríci,
ué’ scázzichi šta chiánca e bbatti a ssuénu
la péddi ti tammúrru e nnonci štracchi.
Šta pparla lu tammúrru senza voci,
cu llu sua tunghi-tunghi, tunghi-tunghi,
‘n capu a cci teni fami ti lu gghiúštu :
“Nnu túmmunu a mmé’,
nnu túmmunu a tté’, massaru Miché !
Nnu túmmunu a mmé’,
nnu túmmunu a tté’, massaru Miché !
Nnu túmmunu a mmé’,
nnu túmmunu a tté’, massáru Miché !…”.
Intr’alla štrata totta nzulagnáta
lu uécchi fissu ti la tarantáta
šta spetta cu lla pongi lu culóri
ti la taránta ca l’é pizzicáta.
Ttacca, viulínu, tágghia cu llu suénu,
tagghiénti comu filu ti rasúlu,
la tantazzióni e lla malincunía !
A šta carósa mia talli rifína,
falla bballá’ cu ccáccia fuécu e rrággia !
“A mmari vani tuni, a mmari vegnu…”,
a ccuddu mari ci ti tesi amóri,
a ccuddu mari ci ti feci amára ;
“ci vecu ca ti ffuéchi, mi ni tornu,
ci vecu ca ti ffuéchi, mi ni tornu”.
Ah, soli, soli ca šta ardi ‘n ciélu,
štrazza li ggiúrni ti li spini amári,
nducíšci šti sciurnáti ti chiatróri,
am piéttu a šta carósa minti priésciu !
Ci mó ti cantu, tu rispúnni a mméi,
rispúnni comu aciéddu cantatóri
ca ntra lla cággia si senti šcattári.
A ddó ti pizzicóu la tarantélla,
a ddá cu bballu e ssuénu vani tuni,
a ddó lu fumu ti cicóu li uécchi,
a ddó la fantasía si ni vulóu…
A bballa, bbédda, comu mai facíšti,
no tti ppuggiári, bballa, bballa, bballa !
Ddurmíšci la taránta tantatríci,
a ccantu e ssuénu, bballa, bballa, bballa !
Šta mbrógghia, Lena comu voli e ssapi
cuddu latuérnu ca pi edda é’ ppani ;
sona Pascáli, senti, nonci veti,
pi nna taránta nfama, traditóra,
ca li štutóu la luci ti lu soli.
Allu círchiu, nna bbotta, e allu tampágnu :
“No é’ ttaránta ca t’é pizzicáta,
cuštu é’ llu tiáulu ci ‘n capu t’á misu…
cuštu é’ llu tiáulu ci ‘n capu t’á misu”,
pi qquédda spica ca tu no ccugghjíšti,
pi ccuddu soli ca tu no vvitíšti.
“Amóri, amóri, cce mm’á fattu fari ?…” :
lu cori allécru mia mó é’ nnu scuróri,
tinía nna bbedda voci, mó é’ bbrucáta,
ticía bbeddi palóri, mó no cchiúni !
“Amóri, amóri, cce mm’á fattu fari ?
Ti quínnici-anni m’á fatta mpaccéri !”.
A bballa, bbedda, comu mai facíšti,
no tti ppuggiári, bballa, bballa, bballa !
Ddurmíšci la taránta tantatríci,
a ccantu e ssuénu, bballa, bballa, bballa !
E quannu ponni la malincunía,
quannu nnu jéntu finu comu seta
ti ccúccia ntra nnu liéttu ti rifína,
oi bbedda mia, ripígghjiti li ggiúrni !
Fešta, uttisciána, sempri allu scampíštru,
lu cori fallu bbáttiri, šciuntári !…
Ca lu sunágghiu ti nna bbona cera
scázzica si faci a rrimmuddári
quédda taránta pronta a pizzicári,
spuntánnu allu pizzúlu ti la štrata.
TARANTOLA
Malinconia: tamburo disperato, opprimente amarezza dentro il cuore, turbinio di sudore, rabbia dentro.
Tu, Lena di “scupètta” [=soprannome] cantatrice, vuoi rimuovere questo peso e suonando batti la pelle del tamburo instancabilmente.
Sta parlando il tamburo senza parole, con il suo tunghi-tunghi, tunghi-tunghi, nella mente di chi ha fame di giustizia: «Un tòmolo [di grano] a me, un tòmolo a te, massaro Michè! Un tòmolo a me, un tòmolo a te, massaro Michè! Un tòmolo a me, un tòmolo a te, massaro Michè!…».
Nella strada interamente assolata l’occhio fisso della tarantata attende che la punga il colore della tarantola che l’ha morsa. Attacca, violino, taglia con il tuo sibilo, tagliente come filo di rasoio, la tentazione e la malinconia! A questa ragazza mia ridona la pace, falla ballare perché espella fuoco e rabbia!
«Al mare vai tu, al mare io vengo…», a quel mare che ti donò amore, a quel mare che ti rese infelice; «se vedo che anneghi, me ne torno, se vedo che anneghi, me ne torno».
Ah, sole, sole che ardi nel cielo, squarta i giorni delle spine amare, mìtiga queste giornate di gelo, nel petto di questa ragazza metti gioia!
Se adesso io ti canto, tu rispondi a me, rispondi come uccello cantatore che nella gabbia si sente morire. Dove ti morse la tarantola, là con ballo e suono rècati, laddove il fumo ti accecò gli occhi, dove la fantasia prese il volo…
Balla, mia bella, come mai facesti, non ti fermare, balla, balla, balla! Addormenta la tarantola tentatrice, al canto e al ritmo, balla, balla, balla!
Sta cantando, Lena come vuole e sa quel lamento che per lei è pane; suona Pasquale, sente, non vede a causa di una “tarantola” infame, traditrice, che gli spense la luce del sole.
Al cerchio, un colpo, e al coperchio: «Non è la tarantola che ti ha morso, questo è il demonio che ti sei messo in testa … questo è il demonio che ti sei messo in testa», per quella spiga che tu non cogliesti, per quel sole che tu non vedesti.
«Amore, amore, che mi hai fatto fare?…»: il cuore allegro mio ora è malinconico, avevo una bella voce, adesso è rauca, dicevo dolci parole, ora non più! «Amore, amore, che mi hai fatto fare? A quindici anni mi hai fatta impazzire!».
Balla, mia bella, come mai facesti, non ti fermare, balla, balla, balla! Addormenta la tarantola tentatrice, al canto e al ritmo della musica, balla, balla, balla!
E quando tramonta la malinconia, quando un vento fine come seta ti copre nel suo giaciglio di pace, o bella mia, riappropriati dei giorni! Nei giorni di festa e in quelli feriali, sempre in libertà, il cuore fallo battere, esplodere!… Ché il sonaglio del buon aspetto si trasforma in musica che stordisce e annulla quella tarantola sempre pronta a rimordere spuntando all’angolo della strada.
Articolo di Sergio D'Amaro
I. FURTIVE LINGUE.
I POETI DIALETTALI DELL’ULTIMA GENERAZIONE IN PUGLIA
Non ci dovrebbe essere
ormai alcun dubbio che il dialetto può andare anche
in Puglia verso una capacità creativo-espressiva liberata
da antichi ritardi. I pochi giovani, al di qua o al
di là dei quarant’anni, che scrivono consapevolmente
oggi in dialetto sentono urgere la situazione di crisi
che investe i linguaggi. Questi si distendono lungo
il patagio epocale che porta dalla civiltà agricolo-artigianale,
organizzata gerarchicamente e attenta all’autorità
della tradizione letteraria, ad una civiltà di massa
caratterizzata da un grande movimento di culture e
subculture alla ricerca delle loro identità, antagoniste
dell’inevitabile omologazione in atto.
Attraverso il testo poetico, il dialetto consapevole si scava numerosi collegamenti sia con i retropiani emotivi e pulsionali di specie psichica, sia con i piani comunicativi di valore più propriamente sociale e linguistico. È capace, cioè, di valorizzare le sensazioni più profonde, i dati meno consci, così come è in grado di sostenere un discorso cha da prevalentemente lirico o gnomico, si fa anche narrativo, coinvolge una cera parte di storia e soddisfa l’esigenza del recupero della memoria comunitaria. Il dialetto vive così in equilibrio tra realtà e poesia, è realistico e simbolico-metaforico insieme, fusione di primitivo e di moderno, semplice e problematico. In quanto sostegno all’igiene mentale e al colloquio tra passato e presente, il dialetto ha significato nelle giovani generazioni che l’hanno adottato un’acquisizione, per così dire, di armonia, su cui innesta nuove tensioni e sovrastanti discorsi di denuncia e di alienazione.
Per la Puglia dialettale degli anni ’80 la svolta è stata inequivocabile, sicché dal Gargano al Salento si può tentare di ridisegnare, sulla trama soggiacente degli ormai affermati Strizzi, Borazio, De Donno e Gatti, un filo rosso che, con prudente beneficio di inventario, tocca i nomi, da nord a sud, di Francesco Granatiero di Mattinata, Domenico Rignanese di Monte S. Angelo, Lino Angiuli di Valenzano (più conosciuto come poeta in lingua), Raffaele Nigro di Melfi (lucano, quindi, ma ormai naturalizzato pugliese), Peppino Zàccaro di Bari, Michele Muschitiello di Bitonto, Salvatore Fischetti di Lizzano (prov. di Taranto).
Granatiero, che ha una notevole consapevolezza formale, fa funzionare il suo dialetto in una direzione anzitutto di recupero della gestualità e del linguaggio antico in cui è inserita una verità indistruttibile. Essa può essere la verità elementare racchiusa nella fattura del pane o nel fuoco del braciere, o può essere il lamento e la rabbia per la condizione del contadino: “I’ av’ ‘anchjì l’acque assenza / tròzzele assenza antenne, tise sope / la préte de la pescine, / p’la corda nfòsse e i mméne / rosse rosse. /I av’ ‘adacqué l’ùrte sere e matine, / abbuuré lu mule, anghjì la pile / alli jaddine. /Ije m’av’ ‘a fé la scarpenéte. /Ije m’av’ ‘a sckanté, i’ av’ ‘a calé / lu panarìdde, accite / la spresòrde (Io dovevo riempire l’acqua senza / carrucola senza antenna, teso sopra / la pietra della cisterna, / con la corda bagnata e le mani /rosse rosse, /Io dovevo adacquare l’orto sera e mattina, / abbeverare il mulo, riempire la vaschetta / alle galline. /Io dovevo farmi la scarpinata. / Dovevo spaventarmi, dovevo calare / il panierino, uccidere / l’aspide sordo).
Ad ogni modo l’individuazione di questo mondo (nella raccolta‘U iréne [Il grano], 1
pres. di G. Tesio, Roma, Ed. Mario dell’Arco, 1983) fino a ieri vivente, non sa fermarsi per Granatiero a schegge pur nobilmente liriche o risentite. Con La ppréte de Bbacucche (la pietra di bacucco, usata per la trebbiatura a strascico), poemetto presentato da G. Tesio per le edizioni ‘ Ij Babi Cheucc’ (Mondovì, 1986), l’autore di Mattinata tenta la misura del racconto, il respiro narrativo che è caratteristica importante della moderna poesia dialettale. Granatiero riproduce un mondo di fatica e di sacrifici, quello della mietitura, in cui sono impegnati collettivamente uomini e animali e la cui posta in gioco è la stessa sopravvivenza. È un piccolo grande affresco che coinvolge tutte le risorse del poeta, sia sul piano formale (Tesio ha sottolineato l’uso delle rime in tutta la loro gamma) che su quello sentimentale e fantastico.
Il Sud, invece, che ci vuole raccontare Domenico Rignanese di Monte S. Angelo nel suo volumetto Quando la terra vive, quando muore, quando chiama (Associazione Pro Monte S. Angelo, s.d.), è un Sud senza aloni fiabeschi, tutto immerso nella sua dura storia di emarginazione e di sfruttamento. I paesi si spopolano e così le campagne. È una realtà che fino agli anni ’60 e oltre ha caratterizzato il mondo rurale del Mezzogiorno. L’emigrazione ha inciso profondamente nella psicologia ella gente e ha reso straniero chi è giunto fino al limite della disperazione: “Quant’anne jà patisce ancore, /e quanta pène? /So’ fatte vecckje: /a falce ne mète ckjù u iréne /e nen ce stè l’arète: /da u munne vularrije / ca me peggkjèsse (Quanti anni devo ancora patire, / e quante pene? / Mi sono fatto vecchio: / la falce non miete più il grano / e non ci sta l’aratro: /dal mondo vorrei / che mi prendesse). La poesia dialettale di Rignanese è lirica e drammatica insieme. Essa si riferisce sì ad una realtà particolare, ma è come se vi riconoscessimo la condizione universale dell’uomo sfruttato e privo di libertà. Piace particolarmente quella sua attenzione alla memoria e attraverso questa la volontà di vivere e di saper resistere. Memoria che serve a ricordare, tra l’altro, le manipolazioni e i ripensamenti di certa politica agricola di questi ultimi anni e quindi gli inganni e le delusioni ricadute puntualmente su chi ora non vuole più ritornare sulle terre ormai abbandonate.
Attraversato da luci drammatiche e inquietanti è il Sud in dialetto dei ‘baresi’ Angiuli e Nigro. Non è il loro un dialetto dell’armonia, recupero difficile ma coerente di una tradizione che va scomparendo, di un dato dimenticato. È invece una lingua mutila e intermittente, coniugata ad un’ironia a volte acre e amara che sa di avere a disposizione solo spezzoni di un popolo trasfigurato e centrifugato dai frequenti lavaggi del cervello.
In Angiuli sembra dominare un certo atteggiamento espressionistico eppure scanzonato, che coglie la durezza della condizione senza alcun pudore: “Frademe e attaneme stonane precuete / senza paiugghie bianghesciate / né cu scubue né cu bresckone / nan se caporne na morta bbone / da chidde quarte de Uasciandòne /pe nan nge scie speguanne minue / pe nan nge scie serchianne mùerue / pe du terrise alla mariole / senza dìsceue o margiale / pe scalià do pelpetagne chine de pennisce scuerze e sagne / jè p’abbevèsce c’avonne muerte // pe strettegghiarse dalla zoche / e petè disce stogghe toche // damme adénze / fillècènze” (Mio padre e mio fratello / hanno sepolture imbiancate / da nessuna calce da nessun pennello / sbagliarono a scegliersi la loro morte / in un paese americano / pur di non vivere da mandorli / pur di non ingoiare muco / e fare un po’ di soldi / senza doverli chiedere alla zappa / e lasciarsi indietro quello scantinato / pieno di
legna sangue sudato / è per resuscitare che non son morti // per liberarsi dalla fune / e poter dire stiamo bene // ti prego basta darmi ascolto / non ho voglia di giocare molto –14: ‘La fine del mondo’, in Iune la luna, Fasano, Schena, 1979).
Per Nigro, ben altrimenti ora consegnato alla cronaca e alla storia letteraria con le sue fortunate opere narrative, il dialetto è un retropiano che può invadere in ogni momento il fronte della lingua (non è anzi il dialetto una della chiavi più efficaci per entrare nelle sue opere, da Il grassiere al premio Campiello I fuochi del Basento ?). è un dialetto che avanza e arretra seguendo i limiti della coscienza, le sue emersioni e immersioni hanno l’alternanza significativa di segnali sempre minacciati di soffocamento, e pur sempre ritornanti dai movimenti ritmici di una musica-armonia ormai attingibile solo a prezzo di una vera e propria deformazione percettiva: “a a /aa /e la ciuccia mia /’ndo stà /iss la te’ / eraeraeraè /ae / ae /tarantella tarantè / tu l’abball / e ie cu te si tu cant /ie m’ingand /si tu grede / ie chiange e rede /tu te ‘ngrass /ma ru sacce / tu vù di’ /osce e crai /sagrefi’ / qua però s’hadda firni’ / rubb e sbaglie / a te grane / a me la paglia / una a te / una a te / una a iss / n’auta a te / ae / ae … (aa/ aa/ e la ciuccia mia / dove sta / lui ce l’ha / tu ce l’hai / eraeraeraè / ae / ae / tarantella tarantè / tu la balli / e io con te se tu canti / io m’incanto / se tu gridi / io piango e rido / tu t’ingrassi / ma lo so / tu vuoi dire / oggi e domani / sacrifici / qua però si deve finire / rubi e sbagli / rubi e sbagli / a te grano / a me la paglia /una a te /una a te / una a lui / un’altra a te / ae / ae…, in Giocodoca, Fasano, Schena, 1981)
Su un piano un po’ scontato di utilizzazione espressiva del dialetto ritroviamo Peppino Zàccaro, nel quale un non secondario registro contemplativo si alterna ad esiti di più pungente e moderna osservazione sociale. Tinte bonariamente ironiche sono, ad esempio, nell’elogio del telefono o nella descrizione dei grattacapi del condominio, entrambi in Bare core mi (pref. di P. De Ruvo, postf. di V. Maurogiovanni e una nota di D. Giancane, Bari, La Vallisa, 1987): “Ognettande m’addemanghe: /velèsse canosce probbete u nome / du cudde cerveddone / c’à ffatte chessa nvenzione. / Ce tu u’acchiamjende fisse fisse / e bbèlle bbèlle / da vecìne o da lendane / pare ca te parle com’a nu crestiane (Ogni tanto mi domando:/ vorrei conoscere proprio il nome / di quel cervellone / che ha fatto questa invenzione. / Se tu lo guardi fisso fisso / e lentamente / da vicino o da lontano / sembra che ti parli come una persona). Drammatico e accorato è invece il lamento della madre di un drogato, che si riscatta egregiamente anche per certo tono di aura jacoponica: “Figghie, figghie mì / jì non t’accapiscke chiù / te so cresciute com’a nu palumme / da quante jive peccenunne / chine, chine de premure / com’a nu buchè de fiure. / Po’, na maldetta ddì te ne sì sciute / e jind’alla droghe sì cadute” (Figlio, figlio mio / io non ti capisco più / ti ho cresciuto come un colombo / da quando eri piccolino / pieno, pieno di premure / come un bouquet di fiori. / Poi, un maledetto giorno te ne sei andato / e dentro alla droga sei caduto).
Ad un dialetto impegnato soprattutto sul recupero di interi blocchi di cultura etnica ci conduce L’àrte de r’alòje di Michele Muschitiello (pref., trad. e note di G. Moretti, ill. di G. Castro, commento musicale di G.Piacente, Bitonto, Grafiche Arcobaleno, 1987). L’opera è un singolare poemetto epico-didascalico sull’arte della molitura delle olive, le cui fasi sono seguite con la puntualità del filologo attento ad ogni movimento ed oggetto. La narratività didascalica del poemetto è ulteriormente sostenuta da numerose illustrazioni che inframmezzano il testo e che hanno nel loro lindore figurativo la vocazione al cartellone del cantastorie.
Ritorna con Muschitiello, ma con una fantasia a volte trattenuta dal rigore formale della composizione, l’elemento comunitario del dialetto, cioè la volontà di circoscrivere ed evidenziare la cultura contadina come cultura sociale e insieme materiale: “A la dì de jòuce l’alòje se fatiche / a re trappètere accàume a r’andòiche, / che ll’àrte ch’a nìue ne jònne ‘mbarèute / r’attèune de r’attèune de re tìmbe passèute (Al giorno d’oggi l’oliva si lavora / nei frantoi come [usavano] gli antichi / con l’arte che a noi hanno insegnato / i padri dei nostri padri dei tempi [ormai] passati). È appena il caso di riflettere sul finale di sapore gnomico, imperniato sull’utilità non solo ovviamente economica del prodotto oleario, ma sull’uso metaforico dello stesso, adatto cioè per ungere le ruote del potere politico. Contro il quale Muschitiello ha continuato, in altre sparse prove in versi, a inveire, denunciando il trasformismo e l’opportunismo che ammorbano il palazzo e realizzando comunque, per questa via, una vena di sapido umore polemico.
L’elogio dei mestieri si rintraccia pure nel libro di Fischetti, Scardi, (pres. di R. Jurlaro, disegni di G. Pisconti, Fasano, Schena, 1982), che mostra tuttavia di aver travasato nel dialetto una gamma più varia di impressioni e un più esplicito spirito di solidarietà politica con i ceti contadini: il che non è tra gli esiti minori della poesia dialettale delle giovani generazioni pugliesi degli anni ’80. il conciabrocche, il seggiolaio, il venditore di paglia recuperano un ‘flatus vocis’ che rimanda ad una realtà il cui versante sentimentale idilliaco è sovrapposto alla violenta condizione della vita-trebbiatolo del contadino-bracciante: “Croc’e ppitrara ti scarùfa-tèrra: / cramègna, scrascì, sguazzi, pètr’e ppètri, / cu lli tassi ca sàgnun’e spògghiunu. /Sti tèrri nuèstri – sotta sbacantuti -,/ mancati comu spugni, pi lli vòri, / nancati comu ncerti ca canoscu, / sanguètti sòntu ti soldi e ffatìa” (Croce e rebbiatolo di mangiaterra: /gramigna, rovi, rocce, pietre e pietre, / con la tasse che salassano e spogliano. /Queste terre nostre – sotto vuote-, /ingorde come spugne, per gli inghiottitoi / ingordi come certi che conosco, / sanguisughe sono di soldi e fatica).
Il passato è visto da Fischetti in funzione del presente. L’abbandono della memoria non permette il passaggio consapevole alla nuova realtà del mondo contemporaneo, che rende i valori soggetti ad un moto rapidissimo e sconvolge, sul piano materiale, gli ecosistemi (si vedano, ad esempio, Li tagghiàti, le cave). Questi nuclei civili e politici della poesia di Fischetti, riconducibili ad un senso molto acuto dei bisogni della comunità, dell’ethnos (a motivi vitali della moderna poesia dialettale), si alternano ad una sensibilità impressionistica notevole, ad una cattura di microrealtà, di fenomeni, di visioni che servono il versante simbolico o sapienziale dell’espressione poetica in dialetto. La memoria significa anche il vicinato, gli odori natalizi, i misteri di venerdì santo, la tarantata; ma permette anche l’occhio tersamene infantile sulla primavera, l’agnello, il venticello, il grano. L’orecchio di Fischetti si rivela così addestrato ad una musica molteplice e versatile che si nutre, più che del formalismo strutturale della rima, di un appassionato scavo in ogni parola che sappia restituire l’organismo tuttora vitale di un dialetto, dei dialetti. Che sono sì marginali, ma hanno tutte le carte in regola per imporre la diversità straniante delle lingue periferiche, altre, delle comunità reali della Puglia e dell’Italia.
Sergio
D’Amaro
[in “Diverse Lingue”,
IV, 6, luglio 1989, pp. 81-89]